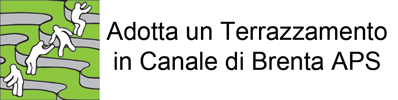Venerdì 3 giugno 2022 toccava a me, alle 20.30, nel salone delle Grotte a Oliero, ero chiamato a parlare del Parco in seno ai festeggiamenti dedicati al bicentenario della scoperta delle grotte. Che poi detta così sembrerebbe quasi na roba alla Livingstone e le cascate Vittoria. Tutto molto meno epico, anche se non privo di un certo fascino storico.
Però è sempre un appuntamento che vuoi onorare. Ti prepari, sai che hai un’oretta e mezza, dopo gli astanti si stancano, perdono la concentrazione, ma devi dire tante cose… va beh ce la faremo, sarò capace della giusta sintesi, non devo preoccuparmi. Poi arriva il momento, inizi, vai avanti, finisci e ti sembra di non aver detto nulla. Il giorno dopo rimugini, ti confidi persino: “non sono stato capace di dire tutto quello che avevo in cuore di dire”.
Qualcuno ti conforta, ma a te resta l’amaro in bocca. A un certo punto spunta un’idea: scrivo tutto quello che avrei dovuto dire e non ho detto, quello che avevo nel cuore e non è uscito. Ti rispondono: è un’idea stupida, ma se ti fa stare bene…
§
Sì, e partirò proprio dal cuore, perché è una questione di cuore. Nel senso che il mio rapporto con questi luoghi è intriso di vita personale. Passioni, cose di famiglia, scoperte.
I luoghi hanno la forza di plasmare le anime, il difficile è narrarlo ed è quello che non mi è riuscito il 3 di giugno.
Avrei dovuto prima parlare di me, perché non ero lì per raccontare con voce da fuori campo, ma per parlare attraverso il filtro del mio amore per quel luogo incantato.
Sono nato a Oliero, e per i primi tre anni della mia vita ho vissuto a 20 metri dal Parco, abitavo in una casetta nascosta dentro a una minuscola corte. Non mi ricordo ovviamente, ma siccome la casa è ancora lì e le prospettive non sono cambiate, deduco che dal terrazzo quel po’ di orizzonte che potevo scrutare chiudeva corto contro i pini di Parolini, i Pinus brutia che stanno sul ciglio del piano alto. Se è vero che i luoghi hanno il potere di plasmare le anime, allora quello scorcio con i tre pini deve aver cominciato a modellare la mia molto presto. Il resto accadde gli anni successivi. Qualche anno dopo infatti mio padre affittò il prato ripido del parco per il fieno. Per arrivarci dovevamo passare sotto ai pini. Erano già vecchi e contorti come ruvide nocche di mano contadina. Sublimi nella loro stoica resistenza alla rupe, al tempo, alla poca terra. Furono loro – assieme ai centenari castagni del nostro castagneto e pochi altri patriarchi che radicavano entro il perimetro delle mie ristrette frequentazioni geografiche – che si occuparono del mio imprinting verde. È facile però dire iniziazione, ma come spiegarlo. Ho cercato a lungo le parole per raccontarmi quello che sentivo in quegli anni. Perché è in quegli anni la forgia, quello che viene dopo è solo inerzia. È in quegli anni che si decide se volerai o grufolerai, per il resto della tua vita.
§
Le ho cercate dappertutto quelle parole. Ho cercato di estorcerle alle labbra della mia gente, ma la mia gente è avara di parole. Le ho cercate dentro ai libri, in tutti i libri, ma non tutti me ne hanno date, solo qualcuno a cui il mio spirito s’inchina ancora.
Le ho cercate ascoltandomi, qualcosa ho trovato.
Le ho cercate dentro alle cose che vivono nella mia terra e anche in quelle che vissero e mi hanno detto molto.

Ho provato a tradurle tutte in lingua corrente, ho provato a trovarne una che le dominasse tutte e mi è venuto “stupore”. Ho capito che senza stupore sei destinato alla tarpatura. Ho capito che lo stupore non puoi indurlo, deve già dimorare nell’anima, ma ho capito anche che lo sveglia solo la bellezza e che ci sono luoghi che sembrano progettati per farlo. Perché sono portatori di bellezza assoluta, quella che non entra solo dagli occhi, ma penetra attraverso il respiro, trafigge la pelle, va a cercare memoria che non sai di avere e come una chiave perfetta apre porte che celano bisogni senza tempo.
§
Ho capito che stupore è mettere in comunicazione quello che è con tutto quello che è stato, che ci portiamo dentro, fissato con la scrittura più antica; riconoscere senza mai aver visto, sentito o udito prima.
Se posso dire con certezza che fu l’intrigante e pittoresca valle che mi accolse, a risvegliare il mio stupore, posso con altrettanta certezza affermare che l’ambiente delle Grotte diede una grossa mano.
Non furono solo i pini, ma anche l’acqua, il vero Genius loci del Parco. Ho pensato tante volte che se alle Grotte dimorasse veramente uno spirito del luogo questo si paleserebbe di sicuro su un sasso muscoso davanti al Cógol Celeste. Però non nelle spoglie di un vecchio barbuto ebbro di saggezza, ma in uno spiritello burlone con la faccia da monello ornata da riccioli neri cadenti sulla fronte madida di rugiada, con nel fondo degli occhi un velo di malignità, sempre pronto a combinarne una. Uno cosciente di essere lo spirito dell’elemento più multiforme dell’intero universo, l’origine della vita stessa, che tuttavia non si vuol prendere troppo sul serio, perché quello che gli garba è giocare con tutto e tutti.
Gli piace creare meraviglie solo per distruggerle, un giorno ti rinfresca e l’altro ti congela. Un giorno ti accarezza e l’altro ti travolge. Alle grotte tutto gli dipende.
Sua è la roccia, creata coi sedimenti di milioni di anni di placide lagune.
Suoi i vacui oscuri, che da millenni modella e percorre sovrano.
Sue le melodie ammaliatrici di fluido leggero che fluttua gutturali gorgoglii su viscide pietre.
Suoi gli alati che con pinne piumate schiumeggiano le trasparenze.
Sua la frescura, che ingrassa il verde dei muschi sui sassi.
Sua la vita e pure la morte.
Suoi i marsoni che con i piedi e le dita tanto fredde che sembravano gonfie, cercavo alzando pietre su trenta centimetri d’acqua gelata. Meraviglie di pesci appiattiti per infrattarsi meglio, grosse teste e branchie che ferivano. Dopo aver tolto con delicatezza la pietra che li celava, un attimo prima che capissero che il loro mimetismo non sarebbe bastato, gli assestavamo na pironà, ovvero li infilzavamo con una forchetta appiattita, a mo’ di fiocina. Gioco maledetto che sapeva di caccia, crudele come la fame, ma esaltante come poco altro al mondo. Il No kill non esisteva e gli scazzoni infilzati finivano nell’olio bollente. Sulla bontà delle loro carni sarebbe meglio che io non mi esprimessi, per pietà verso tutti quelli che non possono più assaggiarle. Una cosa però devo dirla perché riguarda il contesto, certi posti ti restano dentro anche per quel che passa al vaglio del palato. Questo a riprova del fatto che se un luogo ti nutre diventa bello, di un bello che sa di atavico.
La capacità di sentire la bellezza è nata per farci sopravvivere, per guidare le nostre scelte al meglio, non è vero che è bello quello che piace indipendentemente dall’utilità, in filogenesi è bello quello che conviene all’individuo e alla specie. Spesso su questo facciamo confusione, confondiamo l’istinto che ci indica la bellezza con le scelte personali che crediamo completamente libere da condizionamenti.
Chissà come mai dove c’è acqua piace a tutti, anche poca, una pozzanghera da oasi sahariana è sufficiente. Senz’acqua il paesaggio è monco e lo percepiamo senza riflettere, come una mancanza che non esprimiamo se non con la meraviglia nei confronti dei luoghi che invece ne sono ricchi. Poi se l’acqua è fresca e limpida significa niente malattie, significa che puoi berla, che puoi lavarti, che lì puoi vivere. Questa cosa accomuna tutti, e se è patrimonio di tutti ci indica che non può essere frutto di pensiero autonomo, ma a ben pensarci neppure culturale, dato che neanche la più radicata delle culture ha il potere di indurre una tal uniformità di pensiero.
Ma soprattutto ora che abbiamo imparato a dominare l’ambiente, ora che siamo capaci di canalizzare e intubare l’acqua, ora che ce la portiamo in cucina e la facciamo scorrere quando vogliamo, un luogo come l’Oliero dovrebbe aver perso la sua forza magnetica. E invece no, sta sempre lì, con la chiarezza di una disfunzione, a dimostrare che la normale percezione della bellezza è un “ a priori” kantiano.
Un apriori kantiano, qualcosa che ci portiamo nei geni, una specie di regalo filogenetico. Immanuel Kant lo collegava alla morale, ovvero alla capacità di discriminare fra bene e male, indipendentemente dalle appartenenze culturali. Ebbene io penso che di quel a priori faccia parte anche il sentimento che ci guida alla bellezza.
Nessuno di noi dovrebbe sfuggire alla bellezza, tutti dovrebbero avere un “Parco” nei loro ricordi più belli, soprattutto le nuove generazioni che all’armonia andrebbero educate con forza. E fra tutta la bellezza possibile affidarle soprattutto a quella emanata dalle cose che vivono, perché ci appartiene più di tutte le altre. Tuttavia non è detto che coltivare la bellezza alla fine ci salverà vista la corazza di indifferenza che ci è evoluta addosso, ma bisogna provarci perché la posta in palio è di capitale importanza. Bisogna provarci prima che la separazione dallo stupore diventi divorzio dal futuro.
Luoghi come il Parco sono qui per ricordarci che la bellezza esiste e può ancora lavorare per noi.
Da bambino lasciavo fieno e rastrello e correvo a bere da quella sponda dove riposò George Sand, dove forse anche un piccolo Alberto Parolini, disteso a faccia in giù sul greto con le mani poggiate su due sassi muscosi, sfiorava con le labbra accaldate quell’acqua freschissima, prima di bere a sazietà.
Tutto quello che avrei voluto dire e non ho detto. (di Ivan Negrello), Verderame periodico dell’istituto Parolini, 2023